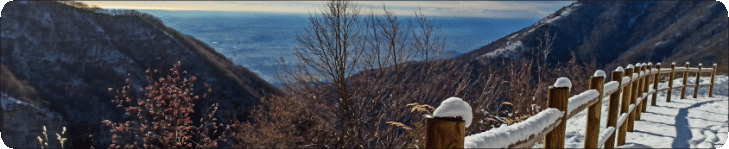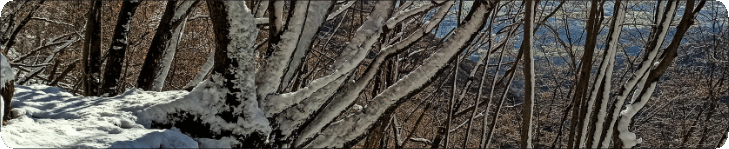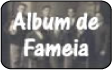|
|||
 Nel nostro paese non troviamo case vecchie oltre i trecento anni, ciò e dovuto a diversi fattori: ristrutturazioni, incendi, terremoti ecc., nel medioevo e nel primo rinascimento sicuramente i nostri avi vivevano in case che avevano i muri in sasso ma sicuramente il tetto in paglia, vivevano all'interno di queste case in promiscuità con gli animali ( mucche, pecore, cavalli..). Nel nostro paese non troviamo case vecchie oltre i trecento anni, ciò e dovuto a diversi fattori: ristrutturazioni, incendi, terremoti ecc., nel medioevo e nel primo rinascimento sicuramente i nostri avi vivevano in case che avevano i muri in sasso ma sicuramente il tetto in paglia, vivevano all'interno di queste case in promiscuità con gli animali ( mucche, pecore, cavalli..). Probabilmente gli unici edifici che avessero avuto un tetto, come noi lo intendiamo, dovevano essere le chiese. Col passare dei secoli però anche i nostri "vecchi" vuoi per le migliorate condizioni sociali ed economiche vuoi per esigenze anche igieniche, cominciarono a costruire case più adatte a delle persone civili e smaniose di vivere in modo più agiato. Grande contributo alla costruzione delle nostre solide e salubri case lo dette fino a non pochi anni or sono il nostro torrente: l'Artugna. Dall'Artugna furono nei secoli prelevate tonnellate e tonnellate di "crode" (sassi) e "gera"(ghiaia), che i nostri antichi muratori con pazienza e tanto sudato lavoro poi trasformarono in case. Possedere una casa è sempre stato il traguardo che ogni dardaghese si è puntigliosamente proposto di raggiungere, la casa significava, come significa ancora, autonomia ed incentivo a fare di più e di meglio.  La caratteristica della tipica abitazione rurale friulana era configurata nel complesso a 'corte' che talvolta comprendeva diverse proprietà, uno spazio chiuso difeso da una cortina o centa
"thenta". Uno spazio comune nel concetto patriarcale di allora di dare asilo sotto lo stesso tetto ai nuclei famigliari che i figli formavano a loro volta nel tempo. Ad essa si accede dalla strada attraverso un ampio
portone di pietra ad arco, sulla
chiave di volta compariva scolpito l'anno di costruzione e le iniziali del primo proprietario. La casa non era un luogo di soggiorno, ma di ricovero, un riparo per uomini, animali, attrezzi e messi. La gran parte della giornata era vissuta nei campi o nella corte
"cortif", fra gli abitanti non c'erano differenze e tutti erano uniti ed attivi nella comunità, con gli stessi problemi le stesse necessità e sotto le direttive indiscusse del
vecchio saggio 'patriarca'. La caratteristica della tipica abitazione rurale friulana era configurata nel complesso a 'corte' che talvolta comprendeva diverse proprietà, uno spazio chiuso difeso da una cortina o centa
"thenta". Uno spazio comune nel concetto patriarcale di allora di dare asilo sotto lo stesso tetto ai nuclei famigliari che i figli formavano a loro volta nel tempo. Ad essa si accede dalla strada attraverso un ampio
portone di pietra ad arco, sulla
chiave di volta compariva scolpito l'anno di costruzione e le iniziali del primo proprietario. La casa non era un luogo di soggiorno, ma di ricovero, un riparo per uomini, animali, attrezzi e messi. La gran parte della giornata era vissuta nei campi o nella corte
"cortif", fra gli abitanti non c'erano differenze e tutti erano uniti ed attivi nella comunità, con gli stessi problemi le stesse necessità e sotto le direttive indiscusse del
vecchio saggio 'patriarca'. La classica famiglia patriarcale dei nostri paesi comprendeva oltre al capofamiglia, due generazioni di discendenti: figli e nipoti, con le rispettive famiglie, quindi potete immaginare quanta e quale concentrazione umana ci fosse in certi "cortif". La stalla "Stale" ed il fienile "tublat" sopra di essa, al quale si accedeva tramite una scala a pioli "pecui", stavano ad indicare che la vita famigliare era indissolubilmente legata al lavoro agricolo, che veniva ancor più evidenziato con orto che ogni casa aveva nelle sue vicinanze. Tale orto recintato "thenta" era coltivato anche a vigneto e garantiva i bisogni alimentari immediati. La stalla era come ben si sa il posto di ricovero di vari tipi di animali, la regina della stalla era comunque la mucca "vacia", seguita dall'asino "mus", dalla pecora "feda" e dal cavallo "ciaval".  In edifici, di dimensioni più piccole, ai lati della corte, trovavano spazio il locale di ricovero dei carri e degli attrezzi,
"lobia" se da un lato era aperta o " tieda" se era un locale chiuso, la porcilaia
"stale del porthit" la stalla dei maiali, il pollaio
"puliner" ed in qualche caso la piccionaia "colombera". La casa in cui abitavano i nostri avi come detto era in pietra dell'Artugna, all'esterno non era intonacata erano adibiti ad abitazione in genere i locali a piano terra e primo piano; nel sottotetto si trovava il granaio
"blaver"; per accedere a questi piani elevati c'era una
scala esterna in pietra che poi si univa a dei ballatoi
"piol" sui quali si affacciavano le porte delle varie stanze o camere "ciambre o ciamere".
In edifici, di dimensioni più piccole, ai lati della corte, trovavano spazio il locale di ricovero dei carri e degli attrezzi,
"lobia" se da un lato era aperta o " tieda" se era un locale chiuso, la porcilaia
"stale del porthit" la stalla dei maiali, il pollaio
"puliner" ed in qualche caso la piccionaia "colombera". La casa in cui abitavano i nostri avi come detto era in pietra dell'Artugna, all'esterno non era intonacata erano adibiti ad abitazione in genere i locali a piano terra e primo piano; nel sottotetto si trovava il granaio
"blaver"; per accedere a questi piani elevati c'era una
scala esterna in pietra che poi si univa a dei ballatoi
"piol" sui quali si affacciavano le porte delle varie stanze o camere "ciambre o ciamere". A questa tipologia di casa si aggiunge in diversi casi nella zona, una variazione che consiste nella casa rustica con sottoportico ad archi di solito questa casa però ha il locale adibito a focolare "fogher" sporgente dal fabbricato. Questa è la forma più evoluta della casa rurale dardaghese, ed anche dei paesi del circondario, risalente al secolo XVI°. Prima la sua struttura era (come già accennato) molto semplice: tutti i locali abitabili erano al piano terra; al piano superiore ,ove ve ne fosse stato uno, c'era il fienile e forse anche il granaio, ricavati sfruttando la forte pendenza del tetto che era ancora in paglia. Il focolare "fogher" era esterno per evitare il pericolo di incendi. Riprendendo la disamina della costruzione rurale dobbiamo ricordare che ad esempio i pavimenti delle stanze adibite a camera erano in tavole di legno, come le travi che reggevano i soffitti. Quelle travi che nelle spaziose se non immense cucine, apparivano annerite dal fumo del focolare presente. Anche le travi del sottotetto adibito a granaio "blaver" erano di legno.Se i pavimenti delle camere e del granaio erano in legno  (in genere castagno "ciastegner" o pioppo nero "talpon"), quelli del pianoterra erano in lastre di sasso ricavate dai massi più grossi che si trovavano nel nostro torrente: l'Artugna. Un esempio ben visibile di questo tipo di
pavimento si trovanella chiesa della nostra pieve, opera di scalpellini e lapicidi locali. In terra battuta o ciotoli accostati "codolat", erano invece i pavimenti delle stalle, dei marciapiedi e dei locali adibiti al depositi degli attrezzi e carri. (in genere castagno "ciastegner" o pioppo nero "talpon"), quelli del pianoterra erano in lastre di sasso ricavate dai massi più grossi che si trovavano nel nostro torrente: l'Artugna. Un esempio ben visibile di questo tipo di
pavimento si trovanella chiesa della nostra pieve, opera di scalpellini e lapicidi locali. In terra battuta o ciotoli accostati "codolat", erano invece i pavimenti delle stalle, dei marciapiedi e dei locali adibiti al depositi degli attrezzi e carri. La luce nei locali era una necessità primaria, ma il costo del vetro e la necessità di avere fresco d'estate ed un po' di tepore in inverno, inducevano a fare finestrelle piuttosto piccole. Nelle stalle le finestre erano ancora più piccole poiché durante l'inverno doveva essere trattenuto quel poco di calore che emanavano gli animali, e che serviva a riscaldare la famiglia quando ivi si riuniva, dopo la parca cena, nelle lunghe e fredde serate invernali, poiché non tutti avevano la legna per poter tenere acceso per lungo tempo il fuoco nel focolare. Il focolare "fogher": esso era ricavato in un vano sormontato da una cappa adornata nel suo perimetro da una mensola dove venivano riposti gli oggetti più differenti. Al centro c'era una base rialzata per il fuoco, fatta di pietra viva o mattoni e sopra pendeva una catena "ciadena" dove venivano agganciati i "paioli" (caldiere), in un lato gli immancabili alari "ciavedal". Negli angoli del vano erano alloggiati due cantonali "cantonai" pensili con anta ribaltabile munita di un gambo in legno, per ottenere un punto d'appoggio, tutt'attorno erano disposte, fissate ai muri, delle panche "bancie"".In questo luogo, che è anche il simbolo dell'unità della famiglia e della gente friulana, i nostri predecessori cucinavano i cibi, bollivano le bevande, si incontravano con gli amici, discutevano, giocavano… L'unica illuminazione era il lume "lum" i più poveri avevano solo candele; in casa era totalmente assente la presenza di acqua corrente. In tutte le stanze i mobili erano ridotti al minimo ed il lusso era una cosa sconosciuta.  Nelle ampie cucine patriarcali c'erano i mobili seguenti: il tavolo "tola" (molto grande) su cui mangiavano gli adulti ed uno più basso e più piccolo su cui desinavano i bimbi, La madia "panera" della farina di granoturco, per la polenta, nella quale venivano anche poste le uova. Una cassa per contenere la legna da ardere nel "fogher" " cassela de le legne e dei s'ciatus". Il secchiaio "segler" dove venivano agganciati i vari tipi di secchi tra i quali anche quelli contenenti l'acqua attinta alla fontana. La rastrelliera "gradela" per appendere pentole e stoviglie: Le panche "bancie"ai lati dei tavoli, e qualche sedia "cariega" o sgabello "sgabel". Di lato della cucina c'era il ripostiglio per le provviste "stanthia", questo locale era posto sempre al nord per garantire un maggior fresco specialmente d'estate, il più delle volte questo locale non aveva finestrelle e forse era l'unico che alla porta aveva una serratura la cui chiave era ben custodita dal padrone di casa! I muri della cucina erano quasi sempre spogli o al limite potevano far mostra di qualche quadretto annerito, di santi o madonne con l'immancabile rametto di ulivo benedetto. Nelle camere "ciambre" trovavamo: il letto matrimoniale formato da due cavalletti, quattro-cinque assi ed un pagliericcio "paion" riempito di brattee di pannocchie di granoturco "scartosse", altri letti similmente fatti erano destinati ai bambini ed alla prole femminile, i figli maschi giunti all'età adolescenziale erano destinati ad andare a dormire nel fienile. Nella camera matrimoniale trovavano posto altri oggetti:la cassapanca del corredo  di biancheria portato in dote dalla sposa ed il trespolo di ferro con brocca, catino dell'acqua per lavarsi viso e mani ( quest'oggetto però è di età abbastanza tarda, secolo XIX°). C'era anche qualche sgabello e qualche sedia, immancabili delle piccole acquasantiere ai lati del letto ed il crocifisso, sotto il "paion" c'era anche in maiolica o ferro il pitale "bucal" per gli eventuali bisogni corporali notturni.A proposito di servizi igienici non esistevano locali adibiti a tale scopo, c'era un servizio diciamo non tanto igienico e consisteva in un gabbiotto
"candotto" di legno o canne di granoturco legate tra loro, la porta a volte non esisteva e all'interno una buca nel terreno e due tavole poste parallelamente bastavano a garantirne la funzionalità. Di solito era posto in un angolo del cortile vicino al letamaio "cort". di biancheria portato in dote dalla sposa ed il trespolo di ferro con brocca, catino dell'acqua per lavarsi viso e mani ( quest'oggetto però è di età abbastanza tarda, secolo XIX°). C'era anche qualche sgabello e qualche sedia, immancabili delle piccole acquasantiere ai lati del letto ed il crocifisso, sotto il "paion" c'era anche in maiolica o ferro il pitale "bucal" per gli eventuali bisogni corporali notturni.A proposito di servizi igienici non esistevano locali adibiti a tale scopo, c'era un servizio diciamo non tanto igienico e consisteva in un gabbiotto
"candotto" di legno o canne di granoturco legate tra loro, la porta a volte non esisteva e all'interno una buca nel terreno e due tavole poste parallelamente bastavano a garantirne la funzionalità. Di solito era posto in un angolo del cortile vicino al letamaio "cort". Queste sono le dimore dei nostri avi e questa è la cultura del lavoro, della famiglia che li ha accompagnati per molti secoli mantenendo, fino a pochi anni fa, aspetti antichi accanto ad altri progressisti. Ancor oggi in quelle pietre "crode" che faticosamente hanno assemblato,si sente pulsare il vecchio cuore di un paese che vuol vivere e progredire. |
|||